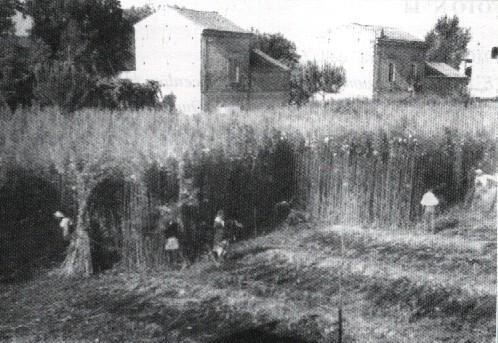Per tantissime persone la denominazione "Centro storico" sta a designare solamente una zona svantaggiata della città, quella in cui non sono consentiti gli interventi edilizi realizzabili, invece, in altre aree urbane.
In realtà la locuzione dovrebbe essere intesa esattamente in modo opposto, cioè dovrebbe far pensare a un luogo privilegiato, dove insiste la parte nobile della città, quella che conserva i caratteri tipici del borgo antico.
È il caso di precisare, in proposito, che Il significato del termine "antico" non va confuso con quello di "vecchio", che sta a indicare qualcosa in stato di abbandono e di degrado, senza alcun valore, e che può essere anche di recente realizzazione.
Definire, invece, antico un manufatto significa riconoscere in esso, oltre alla vetustà, anche valori di natura storica, estetica, ambientale, affettiva, che gli danno pregio a prescindere dal suo stato di conservazione e lo rendono degno di essere salvaguardato ed eventualmente restaurato.
Un edificio antico, al pari di un mobile che abbia la stessa connotazione, conserva i tratti distintivi di un certo periodo storico ed è un reperto prezioso perché rappresentativo di quell'epoca e del modo di vivere del tempo.
Inoltre, il più delle volte, presenta caratteristiche costruttive che testimoniano una sapienza tecnica ed esecutiva che è andata persa col tempo e che perciò rappresenta un modello di riferimento per le maestranze di oggi oltre che un valore da tutelare.
Ma un edificio nel centro storico ha valore non solo se possiede forme architettoniche di rilievo, ma anche se, pur presentando una sagoma semplice e anonima, si inserisce nel contesto in maniera armonica e ne è parte integrante.
Il centro storico rappresenta, quindi, per i piccoli centri, il nucleo antico della città, quello che si caratterizza per la sua uniformità urbanistica e l'omogeneità delle tipologie abitative, spesso interrotta dalla presenza discordante delle trasformazioni moderne che, alterando il contesto originario, stridono fortemente col preesistente.
Questa introduzione era necessaria per un approccio consapevole alla precisazione dei limiti e delle caratteristiche del nostro centro storico.
Per avere un’idea chiara della sua conformazione basta osservare una planimetria della prima metà dell'800 (Fig.1), che, attentamente studiata e analizzata, si rivela una preziosa fonte di conoscenze, curiosità e sorprese.
Innanzitutto focalizziamo l'attenzione sulle principali vie di comunicazione. Guardando in alto la foto, emerge l'ampia e regolare via Nova (a vianova), attuale via Roma. Sul margine destro si nota il suo innesto sulla Consolare Campana, che si pone in direzione obliqua rispetto alla via Nova.
Ricordiamo, come già ebbi modo di scrivere nel post "Alle origini della nostra storia", che la via Campana (attuale via Campanello) è una strada antichissima di origine osca, preesistente perfino all'occupazione romana, e congiungeva Capua (S. Maria C.V.) con Puteoli (Pozzuoli). Essa lambisce marginalmente il nucleo antico del paese e se ne allontana quasi senza interferire.
La Via Nova fu realizzata invece agli inizi del XIV secolo dagli Angioini e risulta immediatamente a ridosso dell’abitato. Ciò non ci deve però indurre a ipotizzare che il paese si sia originato per la presenza di questa strada, dal momento che il nucleo originario era preesistente alla sua realizzazione.
Torniamo quindi a fare riferimento alla via Campana e cerchiamo di capire perché quella strana collocazione del borgo, prossimo alla strada ma da essa defilato.
Per darci una spiegazione dobbiamo risalire all'epoca dei Romani e alla loro consuetudine di dare un ordine geometrico alle terre occupate.
Sul territorio venivano tracciati percorsi carrabili tra loro paralleli in direzione approssimativamente nord-sud denominati decumani ed altri, in direzione ortogonale chiamati cardini. La distanza tra i tracciati stradali era di 705/706 metri e determinava così una griglia quadrata con lotti di circa 50 ettari, denominati "centurie". Ogni centuria aveva, quindi, strade poderali sui quattro lati, con relative cunette per lo smaltimento delle acque piovane, e all'interno poteva presentare altre suddivisioni con analogo andamento regolare.
La Centuriazione che ha riguardato il nostro territorio ha avuto diverse fasi, a partire dal 131 a.C. con Tiberio Sempronio Gracco fino al 59 a.C. con Giulio Cesare.
Se osserviamo con attenzione una mappa dell'agro aversano possiamo ancora intravedere la matrice quadrata che la sottende ripristinando visivamente tratti di strade poderali scomparsi e ricongiungendoli con i percorsi stradali esistenti.
La fig. 3 riporta, appunto, una planimetria dell'agro, con la ricostruzione della griglia quadrata desumibile.
Osservando lo schema raffigurato emerge chiaramente che diversi borghi sono sorti nei punti nodali della maglia (fig.4), dove era più favorita l'aggregazione spontanea di abitazioni. Ciò vale anche per Teverola, sviluppatasi all'interno di una centuria di cui occupa circa la metà superiore. La via Nova, infatti, fu realizzata proprio sul decumano che la delimitava a ovest.
Stando così le cose viene naturale chiedersi come mai l'antico abitato non si sia sviluppato sulla via Campana e neanche sul tracciato viario preesistente alla via Nova, ma su una strada interna dall'andamento sinuoso e irregolare che seguiva i ripiegamenti naturali primordiali del terreno, l'attuale via Garibaldi.
Ebbi già modo di rilevare che detta via risulta ribassata rispetto alle zone laterali e, per questo, ha le caratteristiche di un canalone, quindi, probabilmente, giace in un antico alveo di fiume.
Una risposta plausibile potrebbe essere che la scelta sia scaturita dall'esigenza di ricercare una collocazione discostata dalle strade di collegamento principali, più protetta dai rischi di scorribande e saccheggi da parte di bande soldatesche di passaggio.
Ritorniamo ora alla visione della planimetria dell'inizio del XIX secolo cercando di osservare con maggior dettaglio la conformazione degli spazi urbani come erano all'epoca.
Lungo il lato ovest di via Roma, notiamo solo alcune costruzioni isolate. Tra queste, spicca sulla destra il monastero di Santa Maria delle Grazie, riconoscibile per la sua imponente sagoma. Purtroppo, oggi non rimane alcuna traccia di questo edificio. Sulla parte sinistra troviamo la stessa situazione, a conferma che lo sviluppo abitativo, come già accennato, ha avuto il suo punto di aggregazione all'interno del paese, lungo l'attuale via Garibaldi.
Le abitazioni, dotate di ampi spazi funzionali, secondo il modello della casa a corte, sono concentrate ai due lati della strada, e l'espansione edilizia è avvenuta secondo criteri razionali e organici allo stesso tempo.
Analizzando più attentamente gli elementi presenti nella mappa, emergono diversi aspetti interessanti che meritano un ulteriore approfondimento. Per ora, mi concentrerò sull'area che da sempre è considerata il cuore pulsante del paese: quella che comprende la chiesa, il palazzo baronale e lo spazio antistante che i Teverolesi chiamano da tempo immemorabile "L'are(a d)o' palazzo".
Un primo aspetto che desidero evidenziare, osservando la planimetria del XIX secolo, è che non compare la fila continua di edifici sul lato sud di via Cavour, come invece esiste oggi. Invece, si notano solo alcuni edifici nel tratto centrale, mentre quelli più vicini al Palazzo baronale risultano arretrati rispetto al margine stradale, in modo da lasciare la facciata del maestoso edificio libera da impedimenti visivi per tutta la sua estensione.
Vorrei focalizzare l'attenzione su una particolarità sorprendente rispetto alla situazione attuale. Riguarda l'angolo nord-est della piazza, dove ora si trova l'ufficio postale. È evidente che in quel punto non c'erano edifici e l'area di pertinenza della parrocchia non si limitava al piccolo sagrato antistante la chiesa, ma comprendeva l'intero angolo tra via Garibaldi e via Cavour, estendendosi oltre la linea di proiezione della Regina, il monumento ai Caduti della Grande Guerra.
Nella planimetria si possono chiaramente distinguere le delimitazioni degli spazi e gli edifici presenti. Uno di particolare rilevanza, con una forma rettangolare allungata, sembra occupare approssimativamente la stessa posizione dell'attuale chiesa, sebbene abbia minore larghezza. A questo proposito, le foto 5 e 6 sono molto esplicative: osservandole contemporaneamente, si nota come la distanza tra la chiesa e l'edificio a destra sia inferiore a quella che c'era in passato tra lo stesso edificio e l'antica struttura riportata nella planimetria. Questo ci fa pensare che l'attuale luogo di culto sia stato costruito sulla sua base, estendendosi verso nord-ovest.
La decisione di utilizzare parti di strutture preesistenti, anche se solo come basi di appoggio, potrebbe essere stata determinata da motivi economici o dalla necessità di accelerare i tempi di costruzione. Tuttavia, questo ha comportato adattamenti funzionali e strutturali che hanno generato delle forzature formali e stilistiche evidenti a chiunque si trovi all'interno della chiesa.
L'anomalia più evidente consiste nella disposizione non ortogonale dei muri trasversali rispetto a quelli longitudinali, sicché la pianta dell'edificio risulta sghemba anziché rettangolare. Inoltre, l'asse longitudinale dell'edificio ha una direzione obliqua rispetto alla strada antistante, il che risulta difficile da comprendere considerando lo spazio disponibile. Tutto ciò appare strano e inspiegabile se non si considerano i fattori contingenti e inevitabili che hanno influenzato le scelte progettuali.
Ma dove possiamo ipotizzare che si trovasse l'antica chiesa di San Giovanni Evangelista, descritta nel 1592 dal vescovo Pietro Ursino durante la sua visita pastorale a Teverola? Potrebbe essere stato quel corpo di fabbrica riportato nella planimetria e successivamente ampliato? No, di certo, poiché la sua ampiezza sarebbe stata inadeguata. Pertanto, cerchiamo di formulare un'ipotesi più convincente basandoci su altri indizi o tracce che possiamo rilevare.
Se osserviamo attentamente sulla planimetria l'area occupata dalla vecchia parrocchia all'angolo tra via Garibaldi e via Cavour, noteremo davanti a quell'edificio antico menzionato più volte, il simbolo di una croce che ha il braccio lungo diretto ortogonalmente ad esso e coincidente approssimativamente con la bisettrice dell'angolo tra le due strade.
Secondo la simbologia convenzionale, la croce indica la presenza di una chiesa cristiana in quel luogo, con la facciata, in questo caso, rivolta verso sud-est, cioè, inclinata di 45 gradi rispetto al Palazzo, in modo da essere visibile sia da via Garibaldi che da via Cavour. L'indicazione del simbolo cristiano in quel punto poteva riferirsi solo all'antica basilica.
E allora ci chiediamo: quale potesse essere il rapporto funzionale con l'edificio retrostante che è stato poi inglobato nella nuova chiesa. Probabilmente, quell'edificio doveva essere il transetto della basilica, posto in posizione terminale secondo lo schema tipico delle chiese a croce commissa, o potrebbe anche aver svolto una funzione di supporto al luogo di culto, come sacrestia, casa parrocchiale, ufficio, deposito arredi sacri e simulacri.
Potreste domandarvi perché, sulla mappa, la sagoma della basilica non sia evidenziata in marrone come gli altri edifici presenti. La risposta è che si tratta semplicemente di una scelta di rappresentazione tipografica: è stato tracciato solo il perimetro degli edifici di culto e lasciata in bianco l'area occupata, in modo da sovrapporvi una croce ben visibile che ne sottolinei la funzione. Ho verificato questa ipotesi osservando la stessa planimetria su un'area più estesa del territorio, concentrandomi sulle numerose chiese di Aversa. Ho constatato che, ad eccezione di quelle più importanti come la cattedrale e San Lorenzo, tutte le altre sono rappresentate nello stesso modo della chiesa di Teverola.
Allora, riassumendo quanto emerso dalle osservazioni e dai ragionamenti, possiamo dire che l'antica chiesa di San Giovanni Evangelista, menzionata anche nella relazione del cardinale Ursino come ricca di opere d'arte, doveva trovarsi lungo la bisettrice dell'angolo tra via Garibaldi e via Cavour e la sua facciata doveva prospettare proprio sul largo antistante, visibile da tutti i punti. L'attuale chiesa probabilmente è stata realizzata ristrutturando ed ampliando il suo transetto, per cui si trova ad avere direzione trasversale e prospicienza obliqua su via Garibaldi. Per un maggiore approfondimento si rimanda all’articolo “Alla ricerca della basilica perduta”.