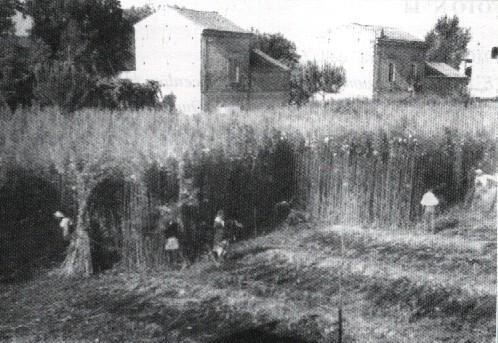Essendo teverolese di nascita, ho acquisito fin da bambino le locuzioni dialettali in uso per indicare le varie zone del paese: All’area ‘o palazzo, Sott a l’ulm, Ncopp o pont.
L’area ‘o palazzo, su cui ho argomentato nel precedente studio, costituiva, come ancora oggi, il baricentro geografico e civico dell’abitato, gli altri due luoghi erano i poli opposti (sud e nord) di via Garibaldi e del paese, dove la strada si piega a gomito per allacciarsi alla Via Nuova e dove si innestano le strade, una volta campestri, di via Dietro Corte I e II.
Le due denominazioni “Sott a l’ulm” e “Ncopp o pont” hanno sempre destato in me una certa curiosità, la prima, perché non ne capivo il significato, e la seconda perché faceva riferimento ad un manufatto di cui non c’era alcuna traccia.
Col passare degli anni mi si è esplicitato l’enigma della prima locuzione; essa era la testimonianza non scritta che nella zona di riferimento doveva esserci stato un olmo secolare dal valore simbolico talmente elevato per la collettività da diventare motivo di designazione di tutta l’area. L'espressione italianizzata “Sotto l'olmo” va letta nel suo insieme e va dato il giusto risalto all’avverbio “sotto” che evoca una chioma ampia, capace di riparare dal sole e dalla pioggia e costituire un luogo ideale per appuntamenti, incontri e adunanze. Non sarà un caso, infatti, se un albero similare sia stato assunto a simbolo rappresentativo per lo stemma del Comune.
Restava da chiarire il mistero del ponte. Quale ponte? E se c’era un ponte doveva esserci anche un corso d’acqua? Dove?
Per dare una risposta a questi interrogativi bisogna fare un tuffo nel passato e immergersi con la mente nello scenario paesaggistico dei tempi remoti.
Com'era il territorio prima che fossero attuate le grandi trasformazioni degli ultimi secoli?
Ipotesi di ricostruzione dell’assetto territoriale intorno all’anno mille (tratto dal testo “Dall’Agro al Comprensorio” di A. Cantile, supplemento alla rivista “L’Universo”)
Dal punto di vista naturalistico dobbiamo rimarcare la presenza caratterizzante del fiume Clanio (Clanius o Glanius in epoca latina, più tardi trasformato in Lanius). Tale fiume, proveniente dalle parti di Marigliano, dopo aver attraversato il territorio tra Nola e Acerra e poi quello di Marcianise, scorreva a circa cinque chilometri da Aversa, e ancor meno da Teverola, andando a sfociare poi nel Lago Patria.
Attraversando le nostre terre, esso disperdeva buona parte delle sue acque lasciando a ridosso delle sponde acquitrini e paludi. Nel fiume si riversavano lagni e rivoli che incuneandosi nel territorio raggiungevano i borghi limitrofi: Teberola, Aprano, Villa Piro (attuale Casalnuovo, frazione di Casaluce).
Mappa del territorio secolo XI
Si sa che il fossato del castello di Casaluce era alimentato dalle acque del Clanio, e così doveva essere anche per il primitivo palazzo prebaronale di Teverola che aveva di certo un ponte levatoio (così come descritto nell'apprezzo del 1642) e probabilmente anche il fossato con acqua.
Le acque del Clanio, a volte, avevano anche un carattere torrentizio e, in modo impetuoso, inondarono più volte nelle epoche antiche l'agro di Aversa arrecando notevoli danni alla campagna e alla popolazione.
Furono i viceré spagnoli a intraprendere importanti lavori di riassetto idraulico del territorio. Le principali opere furono progettate e portate a termine tra la fine del '500 e gli inizi del '600 e ci si avvalse dell'ingegno e dell'opera del grande architetto Domenico Fontana coadiuvato da una numerosa equipe di valenti tecnici. Al Fontana fu dato incarico di "rimediare all'inondazione che fanno le acque sorgenti e piovane in terra di lavoro". Così, furono prosciugate vaste aree paludose e, il percorso del Clanio, eliminando diverse anse, fu rettificato e accorciato e anche incanalato in argini più stabili. Il fiume fu fatto sfociare, invece che nel Lago Patria, 9 km più a nord, in località “Pinetamare" perché la presenza del lago frenava il fluire delle acque e, anche a causa dell'accumulo di sedimenti rilasciati verso la foce, esse tendevano ad espandersi e a ristagnare.
Mappa del 1690 che riporta il percorso del Clanio prima e dopo gli interventi di riassetto idraulico del territorio, con le aree di facile allagamento, le strade e i ponti di attraversamento.
I problemi, però, non furono del tutto risolti e si resero necessarie ulteriori opere di drenaggio con la realizzazione di controfossi e la costruzione di nuovi ponti. Di ciò se ne fece carico Carlo III di Borbone nel XVIII secolo, e, a seguito di tali lavori fu introdotto il nome di "Regi Lagni" in onore dei Reali.
Per arrivare adesso alla questione del ponte dobbiamo chiarire che il Clanio, poi diventato Regi Lagni, veniva da sempre attraversato, per mezzo del Ponte a Selice, dall’antica via Campana, che congiungeva Capua con Pozzuoli e che lambiva anche Teverola.
Tale ponte, spesso in passato, ci informa L.Santagata, è stato causa di liti tra Aversa e Teverola, che, nella figura del suo barone, contendeva ad Aversa il diritto di esigere le gabelle ai passanti. Sarà stato anche per questo che i Teverolesi più anziani, quando ero ragazzo, nutrivano ancora una sorta di avversione e disistima nei confronti degli Aversani.
Allora, riprendendo il ragionamento delineato, quando in passato si diceva “Ncopp o pont” ci si riferiva al ponte a Selice? Credo di no, perchè nella memoria tramandata viene automatico localizzare il posto all’incrocio di via Garibaldi con via Dietro Corte.
Se facciamo caso alle strade che ivi confluiscono, vediamo che tutte pendono in quel punto, sia la porzione di via Garibaldi proveniente da via Roma, sia quella dall'Area o' Palazzo, che la stessa via Dietro Corte, un tempo diretta alla campagna.
Una volta confluite lì le acque meteoriche, quando non c’era ancora la rete fognaria, dove potevano finire? Perché tutto il paese non risultasse allagato dovevano per forza convogliarsi in un corso d'acqua, che poi sicuramente andava a sfociare nel Clanio. Per attraversare questo corso d'acqua ci doveva essere verosimilmente un ponte che, seppure scomparso materialmente, continua a permanere nel linguaggio parlato che si è tramandato fino a noi.
L'olmo e il ponte costituiscono due realtà del patrimonio culturale della nostra città, non più visibili agli occhi, ma presenti nella memoria collettiva che ne attesta la loro storicità.
Tornando al discorso dell'acqua, dobbiamo pensare, quindi, che l’abitato di Teverola sia stato da sempre segnato dalla sua presenza, ora in modo naturale e tranquillo ora con fenomeni tumultuosi. Basti pensare che ancora agli inizi dell’800, nei periodi di pioggia, la Via Nuova si trasformava in un vero e proprio corso d’acqua e, per chi abitava nei casolari di campagna oltre tale via, diventava impossibile attraversarla per potersi recare in paese. Ce lo dice una lettera del 16 ottobre 1811, con la quale il Sindaco "delle Comuni riunite di Teverola, Carinaro e Casignano", Luca Mattielli, faceva istanza all'Intendente della Provincia di Terra di Lavoro perché la chiesa annessa al monastero di S. Maria delle Grazie, che era stata chiusa all'atto della soppressione dell'ordine agostiniano (1809), fosse riaperta "perché quella Chiesa è necessaria per ivi andare la popolazione ad ascoltare la messa, ed esercitare degli altri offici religiosi ne' giorni festivi, e fra l'altro ne' tempi piovosi, da poiché venendo questa Comune attraversata da una orribile lava, non puote la stessa, cioè la popolazione dalla parte di detta chiesa portarsi nella Parrocchia per esercitare gli atti religiosi.”
Alla luce di queste considerazioni credo si possa affrontare in modo nuovo anche la riflessione sull’origine e sul significato del toponimo Teverola. Studiosi diversi hanno dato interpretazioni varie sull’etimo, collegandolo alla nascita del borgo.
L'idea che lungo la via Campana ci fossero taverne di sosta ha indotto alcuni a farlo derivare da tabernola. Ma il termine non sembra riportato in fonti antiche (c’è una citazione del 1480 che riporta Tevernola), quindi è da escludere che sia stato il nome originario.
Un'altra spiegazione sostenuta da diversi studiosi lega l'origine del nome alla produzione agricola di tuberi da cui sarebbero derivati Tuburola e Tuberoli. L'assonanza appare verosimile ma costoro dimenticano che tali denominazioni compaiono soltanto a partire dal 1172 mentre risultano più antiche Tevorola (949) e Teborola (960), come ci informa Franco E. Pezone nelle sue “Note metodologiche…). Inoltre, non credo che i tuberi fossero coltivati in maniera rilevante nella zona. Il noto apprezzo del 1642, seppure di diversi secoli dopo, può essere comunque indicativo sui prodotti tradizionali coltivati: “Produce il territorio grani perfetti migliori del convicino, e di maggior peso……. Produce orzo, fave, ceci, lenticchie, ed ogni'altra leguma. Particolarmente grani d'India, lini, canapi, e questi si maturano nel Regio Lagno per distanza di miglia tre in circa (circa 4 km e ½ ) ….. Produce detto territorio vini perfetti bianchi, come sono asprinii, e verdeschi, e rossi”. Non viene citato, come si vede, alcun tipo di tubero.
Infine, l'ultimo tentativo di spiegazione del toponimo è stato quello di legarlo, come per diversi comuni dell'agro, a nomi di famiglie romane assegnatarie dei lotti della centuriazione a seguito delle note vicende capuane di Annibale. La famiglia romana insediatasi si sarebbe chiamata Tuberani, da cui Tuberoniola, Tuberoila, Tuberola. Ad ogni modo, che si tratti di tuberi o Tuberani, siamo sempre alla radice tub, che compare posteriormente a quelle Tev e Teb.
A questo punto mi chiedo come mai nessuno abbia mai pensato di accostare gli etimi più antichi Tevorola e Teborola, a Tiberis (Tevere), ovvero, far originare il nome dalle caratteristiche fluviali del luogo, tali da suscitare proprio in quegli occupanti romani il ricordo del loro fiume di origine?
Avanzando questa ipotesi, che mi sembra non tanto azzardata, concludo queste divagazioni, scaturite dal desiderio di spiegarmi il perché della locuzione “Ncopp o pont”.
Ringrazio quanti hanno avuto la pazienza di leggere fino in fondo l'articolo e do appuntamento alla prossima lettura: Teverola 3.