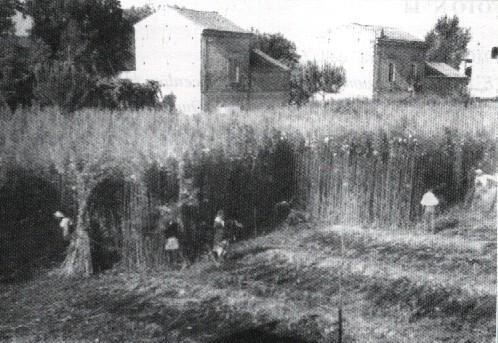Nel post precedente ho indirettamente accennato al rapporto di stretta interazione che c’è stato nel corso dei secoli tra il nostro paese e il corso d’acqua che scorre alla distanza di circa 4 chilometri a nord dell’abitato. Oggi sembra una realtà distante che non riguarda la vita e gli interessi cittadini ma in passato il legame era molto stretto e vitale perché il suo bacino di pertinenza era variabile e ampio e le sue diramazioni si incuneavano fin dentro l’abitato.
Cerchiamo perciò di capire qual era la configurazione di quel sistema ambientale così prossimo a noi da interferire con le tradizioni e le abitudini di vita dei nostri predecessori e di tanti di noi in età giovanile. Chiediamoci pure quali trasformazioni sono state apportate a partire dal XVI secolo e quali di queste abbiano compromesso un ecosistema che avremmo dovuto tutelare perché anche ai giorni nostri ne potessimo godere.
Il fiume Clanio (Clanius o Glanius in epoca latina, più tardi trasformato in Lanius) aveva inizio presso Nola e proseguiva nei territori di diversi comuni, tra cui Marigliano, Acerra, Marcianise e Teverola, andando poi a sfociare nel Lago Patria. In esso si riversavano lagni e rivoli che lambivano i borghi limitrofi che nel nostro territorio erano Teberola, Aprano, Villa Piro (attuale Casalnuovo, frazione di Casaluce).
Il percorso era lungo e tortuoso e le acque tendevano a ristagnare lasciando a ridosso delle sponde acquitrini e paludi. Inoltre, fin dall’antichità, i residui della lavorazione della canapa e del lino sedimentando contribuivano ad ostacolare il naturale deflusso delle acque.
Stando così le cose non c’è da stupirsi se nei mesi più piovosi, quando il fiume assumeva un carattere torrentizio, le inondazioni erano frequenti ed arrecavano notevoli danni alla campagna e alla popolazione. Nei mesi estivi, poi, l’aria diventava irrespirabile per le esalazioni maleodoranti, proliferavano le zanzare e si verificavano anche casi di malaria.
Furono i viceré spagnoli a intraprendere importanti lavori di riassetto idraulico del territorio.
Le principali opere furono progettate e portate a termine tra la fine del '500 e gli inizi del '600 e ci si avvalse dell'ingegno e dell'opera del grande architetto Domenico Fontana coadiuvato da una numerosa equipe di valenti tecnici. Al Fontana fu dato incarico di "rimediare all'inondazione che fanno le acque sorgenti e piovane in terra di lavoro". Così furono prosciugate vaste aree paludose e il percorso del Clanio, eliminando diverse anse, fu rettificato, accorciato e anche incanalato in argini più stabili. Il fiume fu fatto sfociare, invece che nel Lago Patria, 9 km più a nord, in località “Pinetamare" perché anche la presenza del lago frenava il fluire delle acque e, a causa dell'accumulo di sedimenti rilasciati verso la foce, esse tendevano ad espandersi e a ristagnare.
(Vedi foto 1: Mappa del 1690 che riporta il percorso del Clanio prima e dopo gli interventi di riassetto idraulico del territorio, con le aree di facile allagamento, le strade e i ponti di attraversamento.)
I problemi, però, non furono del tutto risolti e si resero necessarie ulteriori opere di drenaggio con la realizzazione di controfossi e la costruzione di nuovi ponti. Di ciò se ne fece carico Carlo III di Borbone nel XVIII secolo e, a seguito di tali lavori, per dare onore e merito al regnante che li aveva promossi, fu introdotto il nome di "Regi Lagni”.
Con la bonifica della zona l’agricoltura rifiorì e i prodotti della campagna (ortaggi, frutta e la canapa) divennero i più famosi e ricercati d’Europa.
Il Clanio, diventato Regi Lagni, era ancora “un fiume limpido e pescoso, meta di scampagnate e di giornate in allegria per tutta la famiglia. Purtroppo la cementificazione selvaggia delle rive l’ha ridotto a canale di raccolta delle acque piovane utilizzate per irrigare i campi, e a sfogo di innumerevoli scarichi leciti e illeciti, rendendolo, in alcuni punti, una cloaca a cielo aperto. Fine ingloriosa di un fiume protagonista della nostra storia”(Salvatore di Grazia).
Lo stretto legame esistente tra gli abitanti di Teverola e i Regi Lagni, a parte l’utilizzazione delle acque per l’irrigazione dei campi, si esplicitava principalmente nella lavorazione della canapa, una occupazione dura e faticosa diversificata in tanti aspetti e momenti lavorativi particolari che, in parte si svolgevano presso i lagni, in parte nei cortili delle case dove avveniva la “maciulliatura” (Foto 2), il cui ricordo è ancora vivo nella memoria di tutti quelli della mia generazione e oltre. Ma di tutto questo faremo una trattazione a parte.
Vorrei ricordare adesso che chi proveniva da Teverola percorrendo la via Campana e voleva raggiungere Santa Maria Capua Vetere, o viceversa, per poter superare il Clanio, doveva passare per il Ponte a Selice.
Tale ponte, scrive Leopoldo Santagata, "è stato spesso in passato causa di liti tra Aversa e Teverola, che, nella figura del suo barone, contendeva ad Aversa il diritto di esigere le gabelle dai passanti". E questa è un’altra curiosità storica degna di nota, che forse spiega il perché di quella certa diffidenza e disistima che da ragazzo coglievo ancora a Teverola da parte delle persone anziane verso gli abitanti di Aversa.
Infine, per chiudere il post, una bellissima notizia tratta dall’articolo di Oreste Paliotti sulla rivista “Città Nuova” del 25 agosto 2022.
Nel luglio 2022 è stato sottoscritto da Governo, Regione Campania, Consorzio e comuni interessati il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che è lo strumento operativo per il quale si affidava allo studio Land dell’architetto paesaggista tedesco Andreas Kipar, autore della riqualificazione paesaggistica della Ruhr in Germania, l’incarico di preparare un documento preliminare di progettazione di riqualificazione dei Regi Lagni in base al quale procedere poi alla gara per la progettazione esecutiva. La fine dei lavori è prevista entro il 2026.
Così scrive il Paliotti:
“Siamo giunti alla vigilia di una nuova fase. Sta infatti per prendere il via un ambizioso progetto di riqualificazione idraulica e paesaggistica che prevede una serie di interventi con criteri tecnologicamente avanzati e sostenibili.
“Se non vi saranno intoppi, la Campania arriverà ad usufruire, per le aree adiacenti i Regi Lagni delle province di Avellino, Napoli e Caserta, di un parco fluviale di circa 700 ettari, fra i più estesi d’Europa e il più grande della penisola; ma soprattutto verranno restituite al mare acque finalmente depurate.
Sono previsti tra l’altro filari di alberi, piste ciclabili, la preservazione del paesaggio produttivo agricolo, un corridoio ecologico che fungerà da autostrada lenta con i suoi collegamenti alle regge di Carditello e Caserta, nonché il recupero dell’area archeologica di Suessola e dell’Oasi naturalistica di Soglitelle a Villa Literno."
Che dire? Sembra incredibile! Siamo talmente abituati a vedere progetti rimasti sulla carta o sviluppati in tempi biblici che stentiamo a credere che tutto ciò possa realizzarsi. Ma in fin dei conti sognare non costa nulla, e ci auguriamo che almeno i nostri figli possano un domani godere delle meraviglie prospettate.